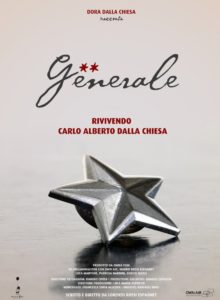21 Novembre 2016 | Vorrei, quindi scrivo
La necessità di sopravvivere e secondariamente la curiosità del vedere cosa c’è oltre hanno spinto l’uomo a migrare. È sbagliato sostenere che le migrazioni sono un’emergenza attuale: sono un fenomeno naturale e da sempre presente, sostenuto da ragione scientifiche dimostrabili.
1000miglia ha avuto l’occasione di porre alcune domande a Telmo Pievani, professore di Antropologia ed esperto di Filosofia delle Scienze Biologiche dell’Università degli Studi di Padova, in occasione della manifestazione ScrittorInCittà 2016.
Secondo lei quali misure devono essere prese perché si possa andare nella direzione di una politica delle migrazioni universalmente sostenibile?
Secondo me bisogna iniziare a lavorare su diversi livelli. Le migrazioni sono un fenomeno che ha delle cause prossime che molto spesso sono legate a motivi politici, a conflitti o discriminazioni. È chiaro che in questo momento siamo in una situazione particolare: abbiamo una cintura attorno all’Europa che va dall’Ucraina al Medio Oriente, senza dimenticare l’Africa Settentrionale che è in una situazione di emergenza unica. Per queste ragioni milioni di persone sono obbligate a spostarsi, in virtù dunque di queste cause prossime. Ma non dobbiamo trascurare il fatto che il fenomeno migratorio è sostenuto anche da cause remote: per esempio spesso dimentichiamo che il conflitto siriano ha tra le sue concause il clima, in quelle terre c’è una siccità fuori ogni misura dovuta al riscaldamento climatico. Per intervenire in modo sostenibile bisogna iniziare a ragionare sulle cause profonde, che richiedono dei provvedimenti politici i cui effetti non possono essere misurati in tempi rapidi ma in tempi piuttosto lunghi. Quindi per esempio lavorare seriamente sul surriscaldamento climatico significa anche lavorare per mitigare il fenomeno migratorio. Se non agiamo in questo senso non possiamo aspettarci che il fenomeno migratorio migliori.
Per lei i confini istituzionali che si sono creati con il progresso sono sinonimo di limitazione o di stabilità?
Dipende, i confini istituzionali non sono positivi o negativi, sono ambivalenti. Sono retaggio storico, però oggi i confini vanno sdrammatizzati, sono un valore se diventano permeabili e motivo di confronto. Se diventano invece identitari e chiusi, a questo punto sono incompatibili con i fenomeni globali cui siamo di fronte. Inoltre dobbiamo ricordarci che le migrazioni vanno in tutti i sensi. Gli ultimi dati ci dicono che in Italia abbiamo perso 100 mila persone, siamo più ad uscire che ad entrare. Va via gente giovanissima, con un tasso di istruzione altissimo, siamo di fronte ad un’emorragia delle nostre intelligente migliori, senza che venga riequilibrata da un rientro equivalente. La mobilità umana è un fiume inarrestabile. Dipende da ogni paese difendere al meglio la propria identità in senso inclusivo, non in senso esclusivo. Quali sono i paesi che hanno saputo far fruttare al massimo l’immigrazione? Gli Stati Uniti per esempio, in certi periodi il Brasile. Sono Paesi che l’hanno regolamentata, che l’hanno gestita, l’hanno valorizzata e l’hanno fatta diventare un’occasione di sviluppo. Bisogna muoversi in questa direzione. La migrazione non va di certo fermata, né devono essere generate paure o costruiti muri. Va gestita sapendo che il migrate ha diritti e doveri. La migrazione di per sé è anche un fenomeno destabilizzante, ed anche per questo motivo va regolamentata.
Esistono prove a sostegno del fatto che il patrimonio genetico dei soggetti di diverse nazionalità presenta omologie sorprendenti, tali da dimostrare che proveniamo tutti da una sorta di comune antenato. A fronte di queste rilevanze scientifiche, come si può spiegare l’esigenza di patriottismo, di segregazione razziale che sembra essere un sentimento proprio dell’uomo?
Secondo me sul patriottismo potremmo discutere. Di recente ho fatto un convegno con Ivo Diamanti, un noto sociologo che ha fatto un’indagine sociologica sugli italiani proprio a questo riguardo: ha cercato di capire quanto il patriottismo è associato ad un atteggiamento di accoglienza. Paradossalmente è emerso come le persone con un senso patriottico forte quindi orgogliose di essere italiane erano anche quelle che non avevano paura del diverso, né di gestire l’arrivo del diverso. Sono rimasto sorpreso, non me l’aspettavo: in genere si pensa che il patriottismo sia un sentimento di difesa dei propri valori, invece non è propriamente così. Si pensi ai Paesi arcobaleno: hanno un senso patriottico ma è costituito dalla diversità incredibile di afflussi e contributi.
L’opinione comune conosce i cardini fondamentali della storia dell’uomo preistorico, che l’hanno fatto evolvere fino ad Homo Sapiens. L’uomo ha cambiato fisionomia, connotati, meccanismi biologici, alterano parametri fisiologici. Ma come sarà invece l’uomo del futuro dal punto di vista evolutivo?
È difficilissimo da dire perchè i motori dell’evoluzione classici non sono più attivi. Ormai siamo diventati globali: separarci geograficamente dando origine a nuove specie non è più possibile. La selezione naturale lavora su di noi più debolmente, perché la medicina, l’igiene, il welfare hanno reso i suoi meccanismi molto meno forti. L’evoluzione che ci aspettiamo è di tipo culturale e tecnologica, che però non è da sottovalutare perché cambia l’ambiente che poi retroagisce su di noi. Quello che stiamo vedendo attualmente per esempio nell’evoluzione della mente umana è come i bambini di oggi sono nativi digitali nel senso che nascono in un ambiente che è diverso da quello dei loro genitori e quindi pensano diversamente. Questa è un evoluzione da tutti i punti di vista: il loro cervello è fisicamente e biologicamente diverso da quello delle generazioni precedenti. Dobbiamo aspettarci questo.
Con la collaborazione di Tommaso Marro
21 Novembre 2016 | Vorrei, quindi scrivo
Chaimaa Fatihi è nata nel 1993 in Marocco dove è vissuta fino al compimento dei sei anni.
Dopo essersi trasferita ha frequentato la scuola primaria e secondaria nella cittadina di Castiglione delle Stiviere (MN) ed ora studia Giurisprudenza a Modena.
Il suo interesse negli abiti del sociale la portano a diventare delegata nazionale dell’Associazione Giovani Musulmani d’Italia al Forum Nazionale Giovani. Lei è una cittadina italiana di seconda generazione ed fiera di essere parte della nostra società. Purtroppo nel corso della sua vita ha dovuto fare i conti con gli stupidi pregiudizi contro la sua religione. Questo confronto che le hai vissuto come arricchimento personale, e non come scontro tra culture, l’ha portata a scrive una lettera a la Repubblica sulla scorta della strade del Bataclan di Parigi. Una lettera in cui lei condanna il fondamentalismo, in cui si può sentire tutto il disagio e la rabbia di una giovane ragazza italiana musulmana che vede l’associarsi della sua religione al fenomeno del terrorismo.
L’incontro è stato incentrato sulle sue esperienze, sulla sua interazione con la nostra cultura e sul suo essere una donna in un’altra religione. Il filo conduttore di tutto il discorso è stata la voglia di presentare un Islam che nella sua radice “aslama” si ricollega alla parola “salām” che significa semplicemente Pace.
Come hai vissuto in prima persona, da musulmana, il confronto con i non-musulmani?
Fino ad appunto le scuole medie non ho mai avuto questa percezione di confronto con qualcosa di differente. Dalle superiori in poi probabilmente ho iniziato a percepirlo maggiormente. Forse perché avevo maggiore consapevolezza di quella che era una mia identità “plurale”, ma l’ho percepito sempre come un arricchimento. Perché in realtà trovavo tante cose che univano piuttosto di quelle che dividevano. Questo per me è stato assolutamente molto importante, quindi in realtà l’ho vissuto sempre in maniera molto positiva.
Però quali sono delle misure concrete da attuare nei processi di integrazione? Mi riferisco a quelli che sono appena arrivati, per esempio i migranti o appunto quelli che hanno maggiore difficoltà ad abbracciare una nuova cultura.
A me piace sempre parlare più di interazione più che di integrazione, perché togliendo quella “g” in realtà, ovviamente con l’integrazione c’è uno che fa uno sforzo per integrarsi nella società, però nell’interazione c’è uno sforzo da entrambe le parti. Quindi la parte che arriva e che è nuova cerca di sforzarsi per esempio nell’apprendere la lingua italiana e conoscere la cultura del paese. Dall’altra però c’è lo sforzo del paese accogliente in cui la società cerca di capire la cultura dell’altro, capire il paese dal quale arriva questa nuova persona. Come processo di interazione c’è questo sforzo reciproco in cui serve lavorare molto sulla lingua che è l’unico modo per esprimersi, per esprimere i propri pensieri. In secondo luogo è molto importante formare una persona a quello che è la cittadinanza attiva e ai valori civili che viviamo nel quotidiano, perché è molto importante. Spesso le persone provenienti da altri paesi non hanno idea anche di quelle differenze proprio di cittadinanza e quindi dei valori costituzionali che magari loro non hanno e che nel nostro paese possono avere. Faccio per dire, il diritto al pensiero e alla libertà di parola non è così scontato per tutti i paesi, mentre noi per fortuna ce l’abbiamo ed è importante anche riprenderlo.
Ma questa interazione deve essere fatta nelle scuole o fuori dalle scuole?
Io penso che serva in entrambi i contesti, più precisamente nella scuole, perché in esse c’è sempre, talvolta, un po’ più di difficoltà, per esempio nel non fare tutto il programma o non riuscire a fare altre cose. Mentre in realtà forse gli insegnanti dovrebbero anche di oltrepassare solo la mera didattica delle regole grammaticali, della matematica, delle equazioni e cercare di fare più progetti per coinvolgere tutti gli studenti anche ad aprirsi e dialogare insieme, cosa che non è scontata purtroppo oggi. Bisogna anche valorizzare questo aspetto della scuola che non è solo di studenti ma di nuovi cittadini.
Ed ora un’ultima domanda. Quali sono i metodi e le forme per divulgare la cultura islamica con cognizione di causa e soprattutto in modo pacifico?
Sicuramente è il leggere tanto tanto tanto e cercare di rivolgersi il più possibile ai diretti interessati, perché spesso ne parlano i non mussulmani e i non arabi o comunque non i diretti interessati e terze persone, quando in realtà facendosele spiegare da chi lo vive in prima persona nel quotidiano si potrebbe avere una comunicazione più efficace ed efficiente.
20 Novembre 2016 | Vorrei, quindi scrivo
Essere la nipote di uno dei simboli della lotta alla mafia e al terrorismo non è affatto facile, soprattutto se quel simbolo è tuo nonno, che è morto svolgendo il suo lavoro poco prima che avessi la possibilità di conoscerlo, di abbracciarlo, di ringraziarlo.
Dora Dalla Chiesa, nipote del Generale Carlo Alberto, ucciso con la moglie Emanuela Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo il 3 settembre 1982 per volere dei vertici di Cosa Nostra, l’ha trovato comunque il modo di ringraziarlo, e ha fatto molto di più: ha fatto si che la storia del Generale Dalla Chiesa potesse continuare ad essere diffusa e ricordata, anche e soprattutto tra i giovani.
L’ha fatto compiendo un viaggio a ritroso nella storia del nonno, incontrando i suoi collaboratori e raccogliendo le dolorose testimonianze dei parenti, in un film-documentario che vi consiglio caldamente di vedere e di cui lascio i riferimenti, e che è stato oggetto, assieme alla vita e all’esperienza di Dora, dell’incontro di Scrittorincittà 2016 rivolto alle scuole superiori di Cuneo a cui ho partecipato.
Alla fine dell’incontro ho potuto rivolgerle qualche domanda.
Ciao Dora, grazie molte del tempo che mi stai dedicando. Mi ha colpito molto nel documentario la risposta di tuo nonno Carlo Alberto alla domanda, durante l’intervista condotta da Enzo Biagi nel 1981, alla domanda “Perché un giovane decide di diventare carabiniere?”. Tuo nonno risponde: ”Certamente perché crede, e quindi perché ha bisogno di continuare a credere”. Credere in cosa?
“Nello Stato, in uno Stato da proteggere, uno Stato che funzioni, in una Legge che difenda davvero il più debole e non sia sempre a servizio del più forte e del più furbo. In questo devi credere se fai il carabiniere. Se fai il carabiniere e non credi in questo non stai servendo nessuno.”
All’inizio del documentario c’è la voce di tuo nonno che dice “[…]Voi non dovete abbandonare certe strade, non dovete pensare che, soltanto perché siete soggetti ad una sconfitta, ad una delusione, ad un sacrificio tutto è vano. No, dovete resistere! Dovete resistere a creare la vostra personalità dal punto di vista intellettuale e morale. Solo allora la vostra persona sarà intangibile alle tentazioni che tanti altri vi porteranno per travolgervi…”
“Questo è un discorso che lui fece ad una scuola di Palermo, lui era Prefetto. Mio nonno era forte, andava nelle scuole disagiate a parlare ai ragazzi, non al Garibaldi (Liceo Classico). Dice appunto ai giovani che se riusciranno a resistere alla tentazione di una via più facile, riusciranno ad essere persone più strutturate, più eticamente giuste, più belle. Lui in quel discorso disse una cosa bellissima, disse che potere non è un sostantivo, ma un verbo. Poter essere liberi in una terra come Palermo in quegli anni era difficilissimo.”
Durante gli anni della lotta al terrorismo (1974-1978), a tuo nonno fu affidata la guida dell’appena nato Pool Antiterrorismo a Torino, per cercare di catturare i rapitori del magistrato Sossi. Egli fu costretto a disobbedire agli ordini per cercare di eliminare totalmente le Brigate Rosse. Quando il Pool stava iniziando a portare risultati importanti, esso venne sciolto, e nessuno dei collaboratori di tuo nonno nel documentario riesce a spiegarsi il perché di ciò, poiché c’era ancora tantissimo lavoro da fare. Quanto coraggio ci vuole a lottare contro un’istituzione in cui si crede ma che costantemente ti mette i bastoni tra le ruote?
“Bisogna pensare che quando si serve lo Stato, si ha sempre a che fare con una sua parte malata. Ci sono, c’erano delle infiltrazioni malate dentro allo Stato, e anche la sua uccisione è il frutto di ciò. Ma se smetti ti servire lo Stato, se smetti di proteggerlo, farai in modo che lo Stato diventi ancora più malato. Allora per questo continui a servire. Ed è quello che fece mio nonno.”
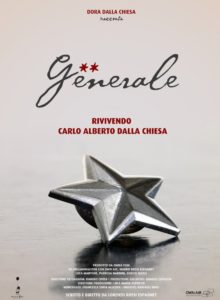
“Generale: rivivendo Carlo Alberto Dalla Chiesa”
Link streaming del film-documentario su Rai Storia http://www.raistoria.rai.it/articoli/generale-rivivendo-carlo-alberto-dalla-chiesa/24417/default.aspx
20 Novembre 2016 | Vorrei, quindi scrivo
Lei dunque capirà è il titolo di un libro di Claudio Magris, in cui l’autore rivisita il mito greco di Orfeo ed Euridice in chiave moderna e da un punto di vista del tutto nuovo. Venerdì sera a scrittorincittà Michela Murgia ha dato voce alle parole di Euridice e i musicisti del conservatorio G.F. Ghedini hanno fatto rivivere la musica di Orfeo.
Claudio Magris nella sua versione del mito mette in luce più la figura di Euridice, che era sempre stata un personaggio senza identità, rispetto a quella di Orfeo. È lei infatti a fare in modo che Orfeo si volti verso di lei, perdendo la possibilità di riportarla tra i vivi. È come se Euridice capisse che il tentativo di tornare al passato non avrebbe portato a niente di buono.
Il titolo del testo, Lei dunque capirà, è la frase con cui Euridice alla fine si rivolge al Presidente dicendo che lui dunque capirà perché lei è ancora lì e non è andata via, nonostante lui avesse dato a Orfeo il permesso di venirla a prendere. Ma è una frase ambigua, non vuole dire solo questo. Significa anche che lei, Euridice, capirà. Nel tempo dell’attesa, nel tempo del cammino, in cui Orfeo la precede e lei lo segue, anche lei intuisce quello che non aveva compreso da viva: capisce che solo gli amori delusi vanno creduti. Gli amori perfetti non sono veri. Attraverso il filtro della morte lei riesce a capire quello che in vita non aveva capito.
Descrive, infatti, questo amore contradittorio, in cui lui la emoziona, la fa diventare una grande donna attraverso i sentimenti che le suscita, ma allo stesso tempo la abbruttisce, la usa, la strumentalizza, le dice di battere lei le poesie a macchina per lui, le mette le corna. È un vero amore, però, perché è un amore deluso. È una grande intuizione che poteva venire solo ad una donna o ad un grandissimo scrittore come Claudio Magris. Il suo sguardo infatti è quello di una donna, innamorato ma allo stesso tempo conscio di che razza di filibustiere ha sposato.
Ci sono dei passaggi in cui lei dice che lo giudica, lo giudica per tutto, lo incolpa per tutto, di cosa non sa bene, ma di qualcosa sempre. Lei è soverchiante, dominante, perché chi ha il potere dell’accusa ha il potere di far sentire l’altro sempre in colpa, lo incatena alla sua stessa insufficienza.
Forse allora non è vero che lo specchio dell’altra parte è esattamente uguale…
In realtà è uguale, ma secondo me quello che Magris dice, e che ha detto a suo tempo anche il mito, è che dall’altra parte c’è una quiete che qui possiamo solo desiderare. Ed è in quella quiete che si vede meglio la nostra frenesia e si capisce meglio quanto poco abbia senso. Dall’altra parte non c’è un tempo che finisce e quindi non c’è fretta, mentre qui sì, qui abbiamo tutto contato.
Con la collaborazione di Anna Mondino
19 Novembre 2016 | Vorrei, quindi scrivo
“Ciao papà, non ti ho conosciuto o, per meglio dire, non mi ricordo di te. Avevo solo un anno quando te ne sei andato. Nel giro di qualche mese un brutto male ti ha portato via. Ora, però, sogno di scambiare qualche parola con te. Ciao papà.”
Basta questa semplicità per introdurre il nuovo romanzo di Walter Veltroni, “Ciao”. Perché non c’è nulla di più vero e spontaneo di un rapporto tra un figlio appena nato e un genitore. Perché non c’è nulla che accomuna tutta l’umanità più che la morte.
Proprio di fronte a questo mistero nasce la voglia del giovane Walter di conoscere il padre. A scuola, dopo le classiche domande “Come ti chiami?” e “Di che squadra sei?”, arrivava sempre la terza: “Che mestiere fa tuo padre?”. Le possibili risposte per il piccolo Walter erano due: una frottola o la verità, anche se questa significava aprire le porte della categoria della morte anche all’amichetto, come a dirgli: “Può accadere anche a te!”.
Gli anni per Walter intanto trascorrono, una mamma forte e determinata e, come tutte le donne, più brava dell’uomo ad affrontare il dolore per quel legame ancestrale e altruistico che la lega con la vita, sempre al suo fianco. Walter cresce, si sposa, impegni giornalistici e politici, ma il desiderio di conoscere il padre non tramonta mai. Quel padre che, anche andandosene presto, ha regalato al figlio un grado ulteriore di profondità e di intelligenza (da intus = dentro; legere = leggere; leggere dentro) nei confronti del prossimo. D’altronde quella ferita lasciata dalla sua prematura scomparsa in qualche modo andava colmata con un dono al figlio.
L’ex segretario del Partito Democratico ha due figlie e dopo la loro nascita aumenta esponenzialmente il numero di pensieri sul suo papà. “Come si fa il padre?” è la domanda che si porta dietro per anni perché la curiosità, nel come affrontare questioni di cui non ha mai avuto un esempio pratico, è immensa.
Così arriva il libro “Ciao”. Un dialogo immaginario con una figura essenziale che si configura attraverso uno scambio di idee, discussioni e una domanda spiazzante di cui ogni figlio ha bisogno di sentirne e conservare la risposta: “Papà, ma tu sei orgoglioso di me?”.
E così, a fine presentazione, con grande e umile disponibilità, Walter Veltroni si ferma per qualche domanda. Dirette, ma pregne di significato, le sue risposte.
Walter, hai parlato di quell’orizzonte nella mente che la mancanza di tuo padre ti ha donato. Praticamente come lo possiamo descrivere?
“E’ il non lasciarsi scorrere le cose addosso e il condividere la propria vita con gli altri. Dobbiamo ritornare ad innamorarci delle storie della vita degli altri. Non ascoltiamo più. Siamo una società piena di paure e necessitiamo di raccontare la nostra vita agli altri per riceverne conferma. In realtà il dono più bello e l’ascolto, poi perché ripetersi la propria storia che già si conosce quando può essere l’aneddoto della storia degli altri a sorprenderci? Comunque la fantasia resta sempre il migliore orizzonte.”
A un giovane di oggi, che consigli daresti per affrontare la vita?
“Dubbi, passioni e sogni sono le chiavi di tante scoperte. Però non esiste la vita facile, comoda, serena. Esiste la vita piena. Ecco, avere dubbi, passioni e sogni per una vita in pienezza.”
Il consiglio più prezioso lasciato alle tue figlie che hai il piacere di condividere con tutti i giovani figli?
“Non pensate solo a voi stessi, la vita diventa noiosa.”
Con una stretta di mano e un “Ciao” Walter Veltroni ci saluta. Nello stesso modo in cui saluta anche all’arrivederci quel papà che non ha mai conosciuto, ma di cui gli sono state testimoniate l’allegria, la serietà, la simpatia e quella luce negli occhi tipica di coloro a cui piace il futuro.
19 Novembre 2016 | Senza categoria, Vorrei, quindi scrivo
Shady Amadi, classe 1988, giornalista, figlio di papà siriano musulmano e mamma italiana cristiana.
Lo incontriamo dopo un dibattito sul tema “Islam, la pace non solo nel nome” insieme a una brillantissima Chaimaa Fatihi, delegata nazionale dell’Associazione Giovani Musulmani d’Italia al Forum Nazionale Giovani.
Abbiamo parlato con lui della Siria e delle conseguenze di questa disastrosa guerra sui suoi abitanti, sui suoi sfollati e sul resto della scena internazionale.
C’è qualcosa che possiamo fare noi? Certamente. Le risposte di Shady vi chiariranno le idee.
La guerra in Siria finirà quando…?
Questo non lo so. Finirà di sicuro quando la comunità internazionale, la società civile capirà che quello che sta avvenendo in Siria è un suo problema. Il fatto è che fino ad oggi questo non è stato compreso, quindi le prospettive non sono buone. E poi il dopo. Finisce la guerra, ma dopo come si ritrova questo paese con mezzo milioni di morti e tredici milioni di sfollati?
Qual è l’alternativa che tu vedi al regime di Assad?
Sostenere la società civile che cerca l’emancipazione dalla dittatura e dal fondamentalismo islamico. Sono ragazzi come noi che perdono la vita quotidianamente nella completa indifferenza della comunità internazionale.

Nel tuo libro (Esilio dalla Siria) dici che spesso i giornalisti definiscono la Siria come un “caos”, e questo non aiuta nessuno, tranne forse il regime e i gruppi fondamentalisti. Il problema è il giornalismo che non si interessa abbastanza alla Siria e non la conosce? Ci sono giornalisti in Siria adesso?
Sì, ci sono giornalisti siriani, sono i citizen journalist che documentano quello che avviene all’interno del paese. Quando io parlo di caos intendo dire che manca la contestualizzazione della notizia, cioè “90 morti ad Aleppo” non basta, devi spiegare al lettore cosa accade ad Aleppo e da quando. Bastano due righe per fornire quel dettaglio in più che aiuta il lettore a comprendere la situazione. E poi descrivere la situazione come un caos significa non voler vedere quello che davvero è accaduto, non mettere insieme i fatti che hanno portato al disastro di oggi.
Giornalisti italiani che coprono la Siria?
Ce ne sono stati molti che sono entrati nel paese e hanno fatto un ottimo lavoro. Il problema è che non sono stati apprezzati quanto invece lo sono stati altri. Io credo che ci sia un altro problema di fondo cioè quanto i giornali vogliono spendere sugli esteri. Il fatto è che credono che gli esteri non diano lettori, allora non gli rivolgono attenzione, e questo è un grosso problema.
Ma che cosa manca in Europa? Mi spiego: perché molti giovani europei decidono di trovare una risposta nel fondamentalismo? Perché partono?
La risposta non è solo il fondamentalismo, c’è anche chi va a combattere in altre formazioni che noi non consideriamo fondamentaliste come le YPG nel Kurdistan. Sono sempre giovani italiani che partono. Un NoTav di Torino (Davide Grasso, ndr) è andato là a fare un video contro Renzi. Lo si poteva fare anche da Cuneo sto video non andando in Siria. Questo è un vuoto che c’è in Europa e che colpisce tutti i giovani. Parlo di un vuoto identitario, un vuoto anche culturale di riferimenti morali, insieme poi a delle società che si stanno sfilacciando, che porta molti giovani a fare queste scelte. In Francia c’è anche il fenomeno della ghettizzazione dell’altro, del musulmano, che ha avuto ripercussioni nefaste con molti che sono andati a combattere. Ma poi qua in Italia, secondo me, come in altri paesi, c’è proprio un vuoto morale, un vuoto di riferimenti. La globalizzazione ci ha talmente tanto intrecciati che io vado a cercare la risposta al fallimento della mia vita in un altro paese, a dare senso alla mia vita in un altro paese, perché senso qua non ce l’ha.

Noi cosa possiamo fare?
Svolgere una battaglia culturale profonda, senza santificare persone. Mettere in crisi anche la cultura che c’è oggi in Italia: chiedere di più di quello che ci viene dato. Noi giovani poi dobbiamo incontrarci, costruire una rete, dibattere tra di noi e impegnarci perché l’impegno manca. Io ascolto tanti miei coetanei – ho 28 anni – che mi dicono: “È inutile che io faccia le cose perché tanto non cambia nulla!”. Questa è la peggiore delle risposte perché non far nulla agevola quello che accade oggi nel mondo del lavoro, negli esteri e in tutto il resto. Invece noi dobbiamo rispondere a quello che non hanno fatto i nostri genitori.