1 Ottobre 2015 | Vorrei, quindi scrivo
Sabato 12 settembre si correva la penultima tappa del Giro di Spagna. Nei grandi giri, quelli infiniti, che si trascinano per settimane e si vincono con le gambe, con la testa e con i nervi, la penultima tappa è quella che conta. L’ultima, se il distacco è abbastanza evidente, la chiamano passerella, perché si entra a Milano o a Parigi, in questo caso a Madrid, quasi tutti insieme, attorniati dalla folla, che applaude l’impegno e la grinta di ciclisti che danno il massimo di sé per kilometri e kilometri, e spesso neanche questo basta.
Sabato 12 settembre, Fabio Aru, sardo di Villacidro, stava a 6 miseri secondi dal leader della corsa, l’olandese Dumoulin e sapeva che ce l’avrebbe potuta fare: lo avrebbe potuto scalzare, per poter nuovamente indossare la maglia rossa, quella che conta avere addosso l’ultimo giorno, sotto il sole di Madrid.
Sabato 12 settembre, davanti alla televisione ho di nuovo imparato tante piccole cose che il ciclismo ti può insegnare, rimanendo pur sempre umile e timido, com’è nel suo carattere.
Ancora una Vuelta, ho imparato che 6 secondi sono tanti, quando li devi recuperare e che sono dettagli, che fanno una grande differenza. Al tuo avversario basta rimanere lì con te, senza troppe preoccupazioni, e tu hai perso. Per soli 6 secondi. Ma hai perso.
Ancora una Vuelta, ho imparato che ci devi credere sempre. Anche se il giorno prima eri distanziato di soli 3 secondi, credevi di poterli recuperare, eri sicuro di farlo, e poi, invece, te ne becchi altri tre. E dopo la tappa sei nervoso, dai l’idea di esserti bruciato l’ultima occasione. In realtà, l’occasione non è mai l’ultima. Se ci credi, ce n’è sempre almeno ancora una.
Ancora una Vuelta, ho visto il gusto amaro e affascinante del mondo della bicicletta, per una volta non sporcato da storie di doping, e fatto di allenamenti, sacrifici, sudore, storie che ti pesano sulla schiena, quando affronti quella salita che sembra non finire più e stingi i denti, perché il segreto non è pedalare più forte degli altri, ma non smettere mai di farlo. Sono la resistenza e la tenacia che entusiasmano il pubblico.
Ancora una Vuelta, ho riscoperto il valore della squadra e quanto sono preziosi quelli che nel ciclismo chiamano “gregari” e che nella vita sono quelli che faticano in silenzio, che sono disposti a fare sacrifici e conoscono il loro ruolo e le loro potenzialità, così bene che fanno il massimo in ciò che sono bravi, senza invidie. Questa Vuelta l’ha vinta il capitano Fabio Aru e nella storia entrerà il suo nome, ma lui per primo sa che è stata la vittoria della squadra, l’Astana, e di gente come Tiralongo, che è stato coinvolto in una caduta e ha lasciato la corsa con 36 punti di sutura in faccia, di Cataldo e Vanotti, ma soprattutto della generosità di Rosa, Sanchez Gil, Landa e Zeits, che sono stati i veri artefici dell’impresa del 12 settembre, perché hanno pedalato insieme al loro capitano e, se possibile, anche per lui, aiutandolo a mettersi le ali ai piedi e a staccare il leader Dumoulin di oltre 3 minuti. Dumoulin era solo. Aru aveva sempre almeno 3 compagni al fianco, o meglio davanti per tagliare l’aria e guidare il gruppo. Un grande gruppo fa molta più differenza di 6 secondi.
Ancora una Vuelta, ho applaudito l’incredibile voglia e costanza di uno come Ruben Plaza, un ciclista trentacinquenne spagnolo, senza l’ambizione di poter vincere la corsa, ma con il sogno di vincere la penultima tappa, che parte da solo, a 114 km dal traguardo, portandosi dietro solo l’incoscienza di chi vuole tentare una fatica immane, davanti al pubblico di casa sua, con il rischio concreto di farsi riprendere dagli altri e magari farsi superare a una manciata di kilometri dall’arrivo, dopo aver combattuto da solo contro il vento per un paio d’ore. Invece, lui scappa e nessuno ha più la forza di riprenderlo, se ne va da solo in quella che, non a caso, chiamano fuga e ti viene da applaudire. Perché ci vuole coraggio e devi continuare a ripeterti “Non mollare!” sotto il casco. La vittoria di tappa è il giusto e onorevole tributo per una scelta, che scoprirai essere giusta solo alla fine.
Ancora una Vuelta, tanti complimenti a Fabio Aru e al mondo umile e timido del ciclismo, che anche quando è popolato da farabutti e corrotti, di affamati di soldi e di vittorie, disposti a tutto pur di ottenerne, è capace di spazzarli via e di ricominciare. E il ciclismo ricomincia con lunghi allenamenti in montagna e poi tappe faticose, nel fango o sotto la neve, e un lavoro esorbitante, buttato via da una caduta, che magari non è neanche colpa tua e ti spacca le coste, e le vittorie leggendarie a braccia alzata tra due ali di folla, in volata o in fuga e le sconfitte, quando in barba alle leggi della logica senti che c’è tutta salita e mai discesa.
Giorni come il 12 settembre, ti fanno venire la strana voglia di inforcare la bicicletta per fare il classico giro della domenica e mentre ci sei, ti fanno pensare a prendere la vita per il manubrio, a fidarti di quelli che ti aiutano ogni volta che possono, a aiutare ogni volta che puoi chi ne ha bisogno, senza chiedere o aspettare una ricompensa, a non farti scoraggiare da nulla, a stringere i denti, quando serve, perché solo così si arriva al traguardo con le mani alzate, in mezzo alla gente festante, con la maglia rossa addosso. Come Fabio Aru.
E mi viene da pensare: dai, ti prego, ancora una Vuelta!
Marco Brero
28 Settembre 2015 | Vorrei, quindi scrivo
Questo non è proprio classificabile come articolo, diciamo che è più uno spunto. Diciamo che ho voglia di condividere una bella storia con voi. Si basa sul dolore in senso lato, su chi per primo ha focalizzato la sua attenzione su questa sensazione e ne ha fatto una scienza. Mai avrei pensato fosse tanto toccante. Non ci sono altre parole per descriverla, è proprio una bella storia. Qui sotto troverete il link per il video, sono minuti ben spesi! Spero che vi piaccia quanto è piaciuta a me!
https://www.ted.com/talks/latif_nasser_the_amazing_story_of_the_man_who_gave_us_modern_pain_relief
21 Settembre 2015 | Vorrei, quindi scrivo
Un altro anno di scuola è iniziato. Lunedì scorso migliaia di ragazzi e centinaia di professori sono tornati a calpestare quei vetusti edifici dove si cerca di trasmettere un’avvincente cultura millenaria agli adolescenti. Conoscenze storiche, letterarie, assiomi matematici e linguaggio informatico dal libro all’allievo, o forse sarebbe meglio dire, dal libro al contenitore. Sì, perché quando un professore entra in classe e, guardando i pavidi alunni del primo anno, esclama “Siete troppi, prima del triennio vi ridurremo”, si perde ogni speranza di umanità in quel luogo dove tra il docente e gli alunni si dovrebbe creare una relazione più umana possibile. Nessuna minaccia, niente ricatti. Una relazione in cui uno dona all’altro ciò di cui l’altro ha bisogno.
A Torino una classe di “primini” ha iniziato differentemente il proprio an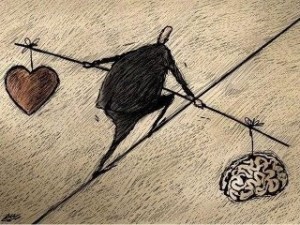 no liceale. Il professore di lettere della prima ora ha portato i ragazzi all’ingresso del Campus Einaudi, il nuovo complesso universitario cittadino. Gli alunni avevano il compito di intervistare gli studenti più grandi. “Sei speranzoso per il tuo futuro?”. “Perchè?”. Ecco le due semplici domande che il prof di lettere ha chiesto ai propri allievi di porgere agli studenti universitari. Due domande forse banali e stupide, ma così semplici da lasciare molti giovani a bocca chiusa.
no liceale. Il professore di lettere della prima ora ha portato i ragazzi all’ingresso del Campus Einaudi, il nuovo complesso universitario cittadino. Gli alunni avevano il compito di intervistare gli studenti più grandi. “Sei speranzoso per il tuo futuro?”. “Perchè?”. Ecco le due semplici domande che il prof di lettere ha chiesto ai propri allievi di porgere agli studenti universitari. Due domande forse banali e stupide, ma così semplici da lasciare molti giovani a bocca chiusa.
Tornati in classe per la seconda ora i dati sono stati analizzati ed emergeva un amaro pareggio tra il sì e il no. Per ogni studente di giurisprudenza uno è fiducioso, l’altro meno. Uno è ambizioso, l’altro rinunciatario. Lo stesso per scienze politiche, economia, lettere, psicologia e così via. Uno ottimista, l’altro più sfiduciato. Scendendo nei dettagli, gli alunni hanno notato che lo scontro tra il sì e il no non dipende dal percorso di studi universitario, ma è una questione interna per ogni facoltà. Giuristi ottimisti contro giuristi pessimisti. Economisti fiduciosi contro economisti sfiduciati. E i perché si dividevano in due battaglioni. Chi è disperato per l’attuale situazione e abbandona le proprie speranze nel diffuso malcontento del saturo mondo lavorativo ancora prima di entrarci, contro chi è energico e grintoso nel voler creare la novità, nel voler dare una boccata d’aria alla propria generazione e al proprio paese in questo mondo così soffocato dal caos danzante di un’economia ripetitiva decennio dopo decennio.
Poco prima del termine della seconda ora, il professore si è messo in piedi dietro la cattedra. Sedia, mano sul bordo della lavagna e poi scarpe sopra il registro con passo deciso. Spinto da quel film che lo iniziò alla sua professione, nelle vesti del prof Keating de “L’attimo Fuggente”, in piedi sulla cattedra, con tono pacato, ma emozionato e emozionante, ha detto: “Ragazzi miei, in questi cinque anni cerchiamo di imparare a sorridere al nostro futuro. Quanto studiamo non dimentichiamolo. Ridiamo, scherziamo e cresciamo uno a fianco all’altro. Leggiamo in Dante e Dostoyevsky noi stessi. Mettiamo qui, insieme, le basi del nostro domani e in questo mondo, dove vivremo insieme l’uno con l’altro, scegliamo noi come guardare alla vita, al futuro. Siamo tutti sulla stessa barca, sta a noi remare in una certa situazione. E con le mie ore di lettere farò di voi giovani che sapranno guardare al proprio domani con la forza di voler realizzare se stessi, scrivendo un capitolo nuovo in quel grande libro ancora bianco che si chiama mondo. E voi e le vostre storie di vita, sarete per me ogni giorno, anzi già siete, uno stimolo nuovo per iniziare alla grande.”
Dopo  il suono della campanella il professore è tornato con la sua borsa a tracolla, lasciandosi la classe dietro la porta, in aula insegnanti ed è andato a sedersi di fronte al professore intento a sterminare i propri allievi. L’uno guardava verso l’alto, l’altro aveva lo sguardo fisso al pavimento. L’incipit di ogni storia liceale è la stessa, aula e banco. Il proseguimento è studio e verifiche. Tutto, forse, o molto probabilmente, dipende dalla prospettiva con cui si affronta la realtà. Vero o falso?
il suono della campanella il professore è tornato con la sua borsa a tracolla, lasciandosi la classe dietro la porta, in aula insegnanti ed è andato a sedersi di fronte al professore intento a sterminare i propri allievi. L’uno guardava verso l’alto, l’altro aveva lo sguardo fisso al pavimento. L’incipit di ogni storia liceale è la stessa, aula e banco. Il proseguimento è studio e verifiche. Tutto, forse, o molto probabilmente, dipende dalla prospettiva con cui si affronta la realtà. Vero o falso?
Nel frattempo si è già alla seconda settimana di scuola.
Luca Lazzari
18 Settembre 2015 | Vorrei, quindi scrivo
Il mio vicino di casa indossa una giacca ormai sgualcita delle olimpiadi invernali del 2006 e delle scarpe dell’Adidas distrutte. Per tutto l’anno. Ha i capelli tutti appiccicati gli uni agli altri e una barba abbastanza incolta da coprirgli tutto il viso, si intravede solo un angolo di guancia. Spesso in mano ha una lattina di birra. Non so se sia piena o vuota, non so se l’abbia comprata lui, oppure se l’abbia trovata per strada, magari in un cassonetto. È sporco e puzza. La sua casa è il marciapiede. Cambia spesso lato, ma rimane sempre nella zona. Lo puoi trovare in piedi che passeggia, oppure seduto per terra. Ma non chiede mai soldi. Lo vedo ogni giorno quando torno a casa, perché quando esco è troppo presto: lui dorme ancora. C’è ogni volta, non manca mai. I suoi occhi non cantano disperazione, né alcuna nostalgia. Sono gli occhi più scuri che io abbia mai visto, non so decifrarli. Non conosco la sua storia. Potrebbe aver perso tutto, oppure potrebbe aver lasciato tutto. Qualcuno potrebbe avergli fatto male, oppure lui potrebbe aver fatto male a qualcuno. Io vedo solo che, con il sole o la pioggia, lui indossa una giacca invernale e delle scarpe distrutte, trascina i piedi sul marciapiede, attraversando gli sguardi della gente che fan finta di non vederlo, e li restituisce indietro, facendo finta di non vedere a sua volta, tutta quella gente.
Mi sono scontrata con un uomo. Era vecchio e in una mano aveva un sacchetto di plastica. Chissà cosa c’era dentro. Nell’altra teneva per il lato più lungo un quadro rettangolare. Era una tela con il volto di una donna dal collo lungo, gli occhi vuoti e a mandorla. I capelli raccolti in uno chignon. Modigliani. C’era la firma di Modigliani sopra. La tela aveva uno squarcio. “Lo squarcio nel cielo di carta”. Da quell’universo bucato, emergeva un nuovo mondo, che era lo stesso di quello da questa parte, ma sembrava diverso. Non ho visto com’era vestito. Non so il volto, la voce, il nome. So solo che un uomo passeggiava per Torino con in mano una tela di Modigliani squarciata. Il privilegio della relatività rende tutto vero. Poteva aver commissionato il suo furto a un ladro giovane, agile e sveglio, che era riuscito nel suo intento, ma aveva squarciato la tela nella fretta della fuga. Poteva essere stato il vecchio a rubarlo, per pagarsi l’affitto o per avarizia. Ma con uno squarcio, quella tela, chissà se valeva il vissuto o valeva solo più una caramella. Oppure voleva quella tela perché la donna nel dipinto era sua moglie, morta giovane, giovane amante di Modigliani, amata comunque da suo marito. Poteva essere lui il pittore, oppure poteva essere un truffatore. Oppure era stato truffato, e quello era un falso. Forse la cosa più vera era quello squarcio.
Sprizza passione da ogni poro della pelle e dai suoi piccoli occhi neri. La puoi percepire nell’enfasi che mette in ogni parola che pronuncia. Il tono è alto, le sillabe scandite. Sa ciò che dice, sente ogni cosa che dice. I suoi discorsi trasudano ansia, aspettativa, eccitazione e paura. Ma soprattutto passione. Quando la incontri per la prima volta, e anche le volte dopo, non sembra tutto questo. Lei si misura. Misura le parole, le espressioni del viso, si misura ma non si nasconde. La sua voce sembra avere addirittura un timbro diverso. Non si fa mai sentire, anche se sa comunque sempre la parte da cui schierarsi. Ammette che spesso non sa cosa dire. Nemmeno io. Confido nel fatto che non deve essere sempre necessario saper cosa dire, per dimostrare che si crede in qualcosa. Ha due anni in meno di me, ma vorrei essere come lei. I suoi pensieri sono rivolti ad un’altra dimensione, quella del futuro, ma con le riserve di tutti quei giorni passati a fantasticare sul domani. E ora a chiedersi se ha fatto bene. Il rito di passaggio, quello che da un sistema ti inserisce in un altro ma ancora non sai come è fatto, quel momento di sospensione che ti esula dal dare forma alla presente realtà, che ti fa svegliare tardi la mattina, annoiare il pomeriggio, e ti fa passare tutto il tempo a pendere dalle labbra dell’attesa, in lei ha la forma della vitalità. Poche volte ho visto tanto entusiasmo in corpi così piccoli. Entusiasmo che da spazi piccoli si espande intorno e ti raggiunge. Non so se esca da ogni poro della pelle o dai suoi piccoli occhi neri. Ma so che quelli si, si possono decifrare. Ma solo se per una frazione di secondo, anche se in un tempo passato, hai visto il mondo attraverso quegli occhi.
12 Settembre 2015 | Vorrei, quindi scrivo
Non sono i piccoli gesti né poche parole a cambiare il corso delle cose, eppure sarebbe sbagliato pensare che la storia va così perché è così che deve andare. Siamo di fronte a una crisi umanitaria che potevamo e dovevamo aspettarci, perché a monte dell’ondata migratoria di cui ogni giorno i mezzi di informazione parlano c’è la guerra. Ed è una guerra che nel silenzio degli ultimi anni ha continuato a divampare, anche se sembriamo dimenticarcene. Proprio per questo, ora i governi e i cittadini europei si trovano nella difficile situazione di dover pensare all’accoglienza dignitosa di migliaia di profughi, che fuggono da una terra inabitabile e da un caos che la cecità dei potenti ha contribuito a creare. Non dico che l’intricato gomitolo della situazione politica del Medio Oriente (ma anche quella del Nord Africa è tutt’altro che chiara) sia semplicemente risolvibile con accordi diplomatici, ma la sensazione è che neanche siano cominciate serie trattative per la pace. Quello che è evidente è che nel mondo che si professa ormai addirittura oltre la modernità, civile e consapevole, ciò che vale di più è ancora la logica della violenza e delle armi. Perciò, risulta incomprensibile la posizione di tutti i governi nazionali e, soprattutto, il fallimento dell’ONU che purtroppo dovrebbe poter controllare il panorama internazionale, garantendo la sicurezza di tutti i cittadini del mondo, mentre appare, invece, un complesso miscuglio di burocrati in giacca e cravatta che ha tempi di reazione lentissimi. Quello che serve, al di là di ogni retorica, è la pace immediata, l’unica condizione attraverso la quale è possibile cercare di garantire a tutti, senza discriminazioni, il benessere, la salute e l’educazione. Potrebbe sembrare troppo semplicistico e ottimista, ma la soluzione pacifica esiste: occorre isolare i facinorosi e favorire una discussione democratica che porti a un esito condiviso dai popoli e dalla comunità internazionale. In mancanza di questo si continueranno a nutrire i regnanti del mondo al contrario: i produttori di armi, i politici di ogni lato del parlamento, dalla maggioranza all’opposizione, che cavalcano le frustrazioni di elettori che vivono un periodo di grave crisi economica, spostando l’obiettivo del dissenso e della protesta su argomenti razzisti o di presunta sicurezza nazionale, i giornali e i mezzi di informazione, che non sempre testimoniano il grave stato dell’arte, ma disegnano ingannevolmente realtà inesistenti, con il preciso intento di vendere qualche copia in più o essere più visti o ascoltati rispetto ad altri. Più di ogni altra cosa, si è scoperto che oltre al gigantesco guadagno che una guerra può creare, c’è un indotto economicamente molto interessante che è quello del trasporto dei migranti. Sono sempre di più le storie di scafisti e approfittatori di ogni genere che promettono la fuga a chi ne ha bisogno vitale: non c’è vergogna più grande di chi si approfitta dei disperati. Insomma, in questo momento storico, l’Europa e il mondo intero hanno una grande opportunità, la si chiami “riscatto” o semplicemente “dovere”, perché è in gioco il significato stesso della parola “civiltà” che spesso ci vantiamo di rappresentare. L’Europa ha l’enorme occasione di intervenire con il suo peso politico (non militare) per avviare le trattative di pace, di inviare aiuti umanitari di qualità, di accogliere chi fugge offrendogli educazione, salute e sostegno in attesa che sia il suo Paese di origine a farlo. E non sarebbero gesti eroici, perché se in questo mondo chi fa il giusto diventa un eroe o un’eccezione, allora la speranza è sempre più fioca. In gioco ci sono grandi responsabilità e parecchi ostacoli, ma difficilmente la via più facile è quella giusta. In questo caso la via più facile sarebbe voltarsi dall’altra parte, aspettando che i rumori del dramma, ancora abbastanza lontani da noi, si affievoliscano da soli. La via da seguire, invece, a mio parere, è quella, prima di tutto, di prendere decisioni a cui molti cittadini si opporrebbero (perché, come direbbe Faber, chi non terrorizza si ammala di terrore), di imporre la pace a chi puntando le armi al cuore di interi popoli urla “Mani in alto!”, non con altra violenza, ma con l’irresistibile forza di una miriade instancabile di mani tese. Perché si tende la mano per aiutare chi è caduto a rialzarsi, per sancire un accordo, per dimostrare vicinanza e partecipazione, per un semplice gesto di pace. Così semplice che sembra impossibile, in questo mondo al contrario che da solo non si raddrizzerà.
Marco Brero
28 Agosto 2015 | Vorrei, quindi scrivo
Il caffè che si ordina al bar per poter andare al cesso. Il tappeto con cui ci si pulisce le scarpe prima di entrare in casa.
Il tedio, la sconfitta, tutte sensazioni annebbiate quando sai di 641immigrati morti nel mare vicino a casa tua.
Lo sgomento si dilegua quando scopri che in quella stessa barca, è nata una bambina. Francesca Marina. In mezzo alle onde, alla fame, al freddo e alla disperazione, la vita resiste. La vita è più tenace di qualsiasi orrore. La vita se ne frega delle onde, della fame, del freddo e della disperazione.
Nello stesso momento dall’altra parte del mondo – ma neanche troppo lontano- nasce Charlotte, attesa da tutto il mondo. Non sa cos’è, ma in testa ha già la corona di una principessa. Il sollievo di nascite inaspettate è spazzato via dalla vergogna, perchè la piccola Charlotte ha una coperta più calda di quella che avvolge il corpicino di Francesca, nonostante entrambe siano fatte di vita nello stesso modo. Nonostante il progresso, l’evoluzione, la storia e i nostri mille passi avanti, retrocediamo sulla questione delle origini. Le cose cambiano, per non cambiare mai: Francesca dovrà farsi strada con i gomiti per andare avanti. Charlotte, invece, a suon di ordini.
La vergogna sparisce, lascia posto alla paura. Oggi in una settimana costruiamo palazzi, ma bastano 10 secondi e un terremoto spazza via tutto. Il Nepal, sommerso dal cordoglio di 7365 vittime, si attenua nell’eco di una trascorsa novità, che appena esplosa fa notizia, ma poi ne rimane una lieve sfumatura, non più percepita da chi si è abituato a sentire il nome “Nepal” al telegiornale.
Distruzione, sospensione, terra, baracche. Il terremoto che ha spazzato via tutto è stato spazzato via dall’onda mediatica dell’Expo, famoso per i suoi ritardi e dei suoi black block. Qui distruzione fine a se stessa, dettata dall’ignoranza e dalla stupidità di chi si annoia ad avere una vita normale.
La normalità spazzata via da un aspirante medico, quando per la prima volta, ausculta un cuore. La sensazione di riuscire, l’ebbrezza del fare, la volontà di rifare. Quella prima volta non la proverà mai più.
La prima volta che qualcuno lascia qualcuno. Per andare alla ricerca di cosa poi?
La prima volta che qualcuno viene tradito da qualcuno. Per provare che cosa poi?
La realtà trasportata in un incubo. Gli incubi reali non ci lasciano stare nemmeno di notte. È per questo che il buio fa paura. Svegliarsi di notte con le lacrime agli occhi, con in testa il trauma dell’abbandono, del tradimento, dell’impotenza. Non abbiamo potere sulle scelte degli altri. Se qualcuno decide di andarsene, se ne va. Anche senza una motivazione.
L’abbandono e il tradimento legate alle vicende personali, perdono senso di fronte ad un campo di concentramento. Di fronte alla più piccola, ma così reale possibilità che un settimo del tuo sangue sia passato di qui. In queste mura, ha guardato lo stesso cielo, calpestato la stessa terra, percorso gli stessi passi che ora stai percorrendo tu ora, in quello che un tempo era un campo di concentramento, oggi un museo a cielo aperto. Di giorno fa paura. Di notte ancora di più. Perde senso ogni cosa, di fronte a questo timore. Forse un settimo del tuo sangue è passato di qua. È stato picchiato qui. Ha visto morire i suoi amici dove ora hanno istallato i bagni per i turisti. Oppure è stato rinchiuso in una stanza. Quella dove ora, per scherzo, col riso fin troppo superficiale, ci rinchiudono i ragazzi, “perché così provano cosa è stato per loro”.
Un settimo del mio sangue è passato di qua. Perdono senso le quotidiane mancanze. Perde senso il sentirsi come il caffè che si ordina al bar come scusa per andare al cesso. Perde senso essere il tappeto su cui ci si pulisce le scarpe prima di entrare in casa. Perde senso tutto.
Ciò che prima dava un certo senso al quotidiano, è spazzato via dalle vicende dell’umanità.
Perfino la sensazione di inutilità perde senso. Ma se il senso ce lo costruiamo nel quotidiano, se viene a mancare, cosa rimane?
Come un film in cui muore il protagonista, perde senso il finale. Abbiamo bisogno di lieti fini. Eppure, se non ci sono neppure nei film , come possono esistere nella realtà?
Siamo alla ricerca di senso. E ci inganniamo ogni giorno, cercandolo nel fondo delle tazzine di caffè.

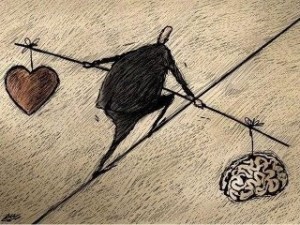 no liceale. Il professore di lettere della prima ora ha portato i ragazzi all’ingresso del Campus Einaudi, il nuovo complesso universitario cittadino. Gli alunni avevano il compito di intervistare gli studenti più grandi. “Sei speranzoso per il tuo futuro?”. “Perchè?”. Ecco le due semplici domande che il prof di lettere ha chiesto ai propri allievi di porgere agli studenti universitari. Due domande forse banali e stupide, ma così semplici da lasciare molti giovani a bocca chiusa.
no liceale. Il professore di lettere della prima ora ha portato i ragazzi all’ingresso del Campus Einaudi, il nuovo complesso universitario cittadino. Gli alunni avevano il compito di intervistare gli studenti più grandi. “Sei speranzoso per il tuo futuro?”. “Perchè?”. Ecco le due semplici domande che il prof di lettere ha chiesto ai propri allievi di porgere agli studenti universitari. Due domande forse banali e stupide, ma così semplici da lasciare molti giovani a bocca chiusa. il suono della campanella il professore è tornato con la sua borsa a tracolla, lasciandosi la classe dietro la porta, in aula insegnanti ed è andato a sedersi di fronte al professore intento a sterminare i propri allievi. L’uno guardava verso l’alto, l’altro aveva lo sguardo fisso al pavimento. L’incipit di ogni storia liceale è la stessa, aula e banco. Il proseguimento è studio e verifiche. Tutto, forse, o molto probabilmente, dipende dalla prospettiva con cui si affronta la realtà. Vero o falso?
il suono della campanella il professore è tornato con la sua borsa a tracolla, lasciandosi la classe dietro la porta, in aula insegnanti ed è andato a sedersi di fronte al professore intento a sterminare i propri allievi. L’uno guardava verso l’alto, l’altro aveva lo sguardo fisso al pavimento. L’incipit di ogni storia liceale è la stessa, aula e banco. Il proseguimento è studio e verifiche. Tutto, forse, o molto probabilmente, dipende dalla prospettiva con cui si affronta la realtà. Vero o falso?