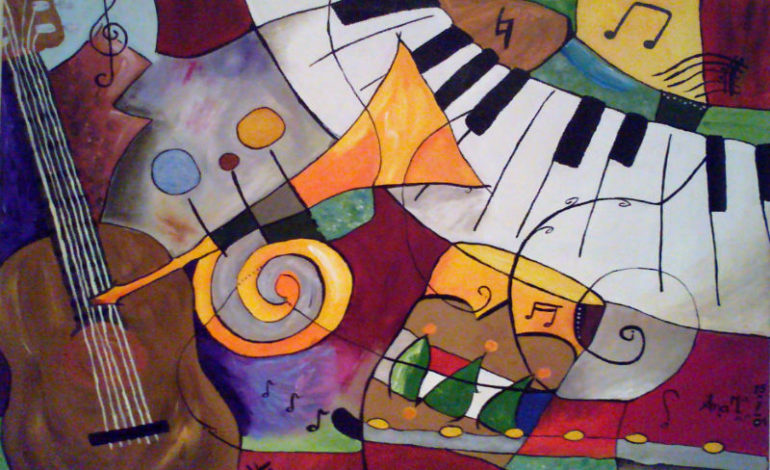Per mia formazione e per il mio carattere raramente mi espongo apertamente su argomenti di grossa portata. Temo incredibilmente di non uscire vivo in un confronto con qualcosa più grande di me, come possono essere i classici. Tuttavia, con questo articolo colgo l’occasione per sollevare una gracile argomentazione a favore di tutta la musica approdata nel mondo degli ascolti classici e le cui riproduzioni reiterate hanno prodotto una generale e diffusa frustrazione. Quindi perché continua a essere fondamentale ascoltare i classici e perché è importante la loro preservazione?
Prima di cominciare occorre probabilmente definire cosa s’intenda per “classico”.
Un’opera diventa un classico quando riesce a scavalcare l’epoca in cui è stata generata, garantendosi una sopravvivenza protratta nel tempo o, in alcuni casi, anche innumerevoli vite. Un classico è qualcosa di antologizzabile, che attraverso lo studio può essere in grado di trasmettere valori più o meno universali. Detto ciò, è lecito chiedersi quand’è che un’opera d’arte viene promossa a questo grado. Italo Calvino nel suo saggio Perché leggere i classici ci fornisce alcuni importanti spunti per rispondere a questa domanda, applicabili anche nel campo musicale. Qui riporto qualche esempio interessante:
«D’un classico ogni rilettura è una lettura scoperta come la prima»
«Un classico è un’opera che non ha mai finito di dire quel che ha da dire»
«Un classico è un’opera che provoca incessantemente un pulviscolo di discorsi critici su di sé, ma continuamente se li scrolla di dosso»
Traslando queste definizioni al mondo musicale, noterete quanto calzino ancora alla perfezione. Pensate a brani come Sweet Child O’ Mine, Heroes o Back in Black e a tutte le volte che li avete ascoltati. Malgrado tutto, c’è sempre un elemento (uditivo o semantico) che sfugge alla nostra attenzione e rimette in loop il sensazionale smarrimento di una prima volta. L’ascolto dei classici ha proprio il ruolo primario di farci ritornare con umiltà dalla parte dell’allievo, dell’ignoranza colmata dalla curiosità. Il fatto che molti appassionati si siano stancati dei classici denuncia che crescendo hanno dimenticato come scindere il puro ascolto musicale dalla cultura stratificata dietro una canzone e dal ruolo che ha ricoperto. Un esempio cristallino è la già citata Sweet Child O’ Mine, canzone rock favolosa e splendidamente genuina, ma simbolo di una cultura morta e nostalgica. Non a caso il testo e l’arrangiamento strappati a quel contesto risplendono di una vitalità che resta facilmente impressa, qualsiasi sia la vostra età.
La preservazione dei classici, intesa come giusto avvaloramento e insegnamento, diventa così facendo il filo conduttore dell’esperienza umana, un prezioso strumento per comprendere il passato e immaginare il futuro. In un momento di grandi trasformazioni in campo musicale (come la morte del sistema pre-anni 2000) la conoscenza dei classici è ciò di cui abbiamo bisogno per lenire il dolore fisico del cambiamento e per plasmare efficacemente nuovi canoni d’ascolto. La retorica del disprezzo dei classici ha il difetto di non offrire un’alternativa ugualmente potente. Le classifiche musicali, piene di canzoni dal sentore quasi usa e getta, hanno smesso da qualche anno di seguire la rotta della ricerca dei classici preferendo il consumo insensato di slavati singoli musicali (in realtà, non fraintendetemi, in circolazione è rimasta anche ottima musica). In fin dei conti, ciò che ha realmente importanza non è tanto il genere di musica, ma il modo in cui siamo indotti a percepirla. La paura più grande in questo caso è semplicemente lo spegnimento di un processo di lunga data i cui benefici sono di innegabile importanza. La mancanza di nuovi classici non farebbe altro che accrescere la forza di quelli già esistenti nella direzione pavida dell’immobilismo nostalgico.