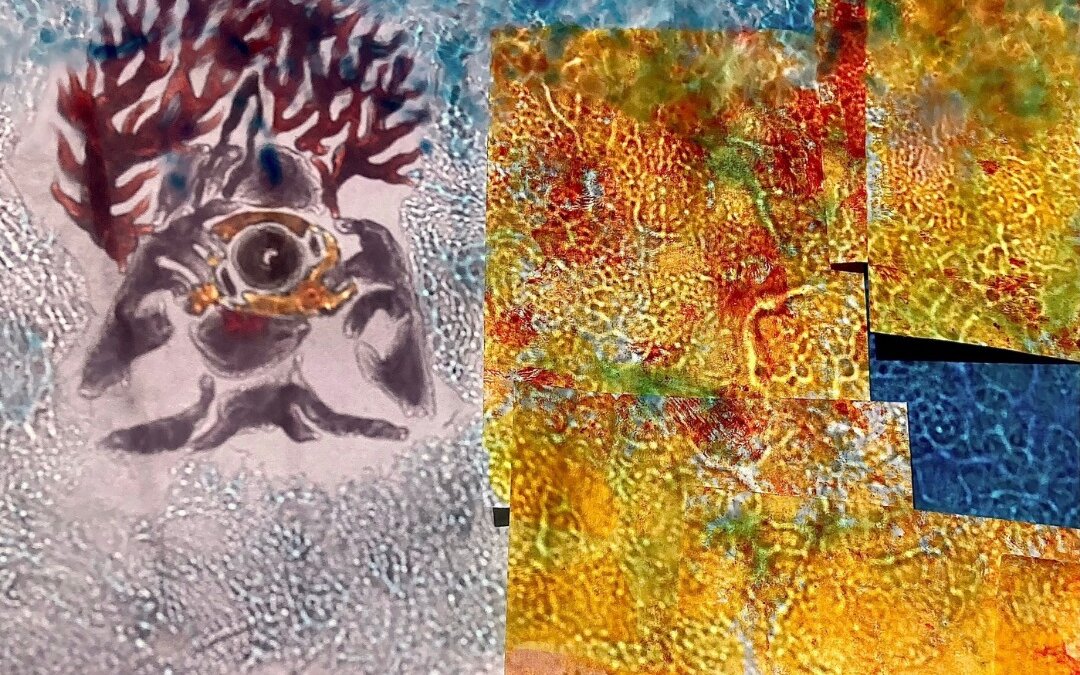In vista del 24 Settembre 2025 alle 18, alla libreria Stella Maris, dove si parlerà d’istruzione
Siamo sicurə che il sistema scolastico ci aiuti davvero a sviluppare un pensiero critico e prepararci al futuro?
Questo è uno degli interrogativi chiave di “Una cosa che non parla”, il nuovo libro di Giuseppe Nibali (2025), con il contributo di Alessandro Barbero.
Un dialogo tra studentə e insegnanti su ciò che si è perso nella scuola: l’ascolto, la crescita personale, la curiosità e l’apprendimento oltre il libro di testo.
Ci siamo posti l’interrogativo anche noi.
Oggi le scuole sono aperte, sì, ma molte ieri si sono fermate – o hanno rallentato – in favore di uno sciopero a sostegno degli accadimenti nella Striscia di Gaza. Un gesto, una manifestazione di solidarietà e di presenza. Una scelta consapevole di chi ha potuto ragionare criticamente intorno ad una delle tematiche che sta scuotendo il mondo e ha voluto intervenire, muoversi. Riguardo a questa capacità critica, questo mercoledì, il 24 settembre, la libreria Stella Maris di Cuneo ospiterà un dialogo incentrato su questo tema in cui a parlare troviamo l’insegnante e giornalista Giuseppe Nibali, che presenta il suo libro ” Una cosa che non parla” , l’insegnante di Lettere del Liceo De Amicis di Cuneo Nazareno Garelli, la psicoterapeuta Maura Anfossi e, infine, la nostra presidente Denise Arneodo.
Il loro incontro, che sarà alle 18 – a cui siete tutti caldamente invitati – toccherà uno dei capisaldi della struttura della nostra nazione: l’istruzione.
Ogni anno, a settembre, ma direi già anche nel mese di agosto, con l’imminente ritorno sui banchi, tutti i centri commerciali d’Italia – e non solo – diventano delle bacheche di zaini, diari, portapenne, quaderni ad anelli, matite, biro, bianchetti, gomme, compassi, righelli, squadrette, portalistini e via dicendo. Le città tornano a gonfiarsi di ragazzine e ragazzini che attraversano le strade, si raggruppano di fronte agli ingressi e nelle piazze. Su quelle stesse strade il traffico, dopo la pausa di riflessione della stagione estiva passata, rimette a dura prova la pazienza italiana ad ogni incrocio. Ma, al di là anche degli aspetti più concreti, il rientro a scuola chiama in causa una valanga di interventi, riflessioni e pensieri di professionisti e non che si interrogano sull’andamento del nostro sistema scolastico. Voti, maturità, orari, bocciature sono piccoli punti di un elenco enorme che troviamo scritto sulle lavagne italiane ogni anno, e che forse, dalla riforma Gentile a questa parte, intende ragionare sul funzionamento del nostro sistema. Senza stare a chiederci più di tanto se questo marasma di dibattito porterà dei frutti o meno, noi, come redazione di 1000 Miglia, abbiamo deciso di dare il nostro contributo. E allora pure noi, come Giuseppe Nibali, ci siamo fatti quella domanda che sta lassù, in alto, in cima a questo articolo. Nella speranza che anche un marasma caotico riesca a dare frutto. Soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo.
La scuola italiana è abbastanza brava a trasmettere nozioni, diciamo di sì e pensiamo al fenomeno dei “cervelli in fuga”.
Però oggi è innegabile sottolineare come sia necessaria una svolta: certo, le nozioni è giusto che ci siano e possono anche mantenere un ruolo di priorità all’interno del processo di apprendimento delle future leve, ma serve spazio per la libertà. Sì, c’è bisogno di una libertà di scoprire il mondo intorno a sé attraverso le nozioni imparate sui banchi senza rimanere imprigionato dalle stesse. Ma, soprattutto, c’è bisogno che ciascuno di noi impari a conoscere dove cominci la propria libertà e dove finisca, cioè, dove comincia la libertà di un altro. Il pensiero critico deve essere atto ad evitare lo sviluppo di preconcetti nei confronti della realtà e di chi la vive. Sarebbe importante una scuola capace di trasmettere nozioni discutibili, o, come direbbe il buon filosofo novecentesco Popper, falsificabili.
Forse intendo dire che la scuola potrebbe insegnarci anche che possiamo sbagliare, e che una conoscenza non è sempre definitiva, non è sempre perfetta. Perché la verità è un concetto complesso. Come il mondo e chi lo vive. La scuola potrebbe soltanto provare ad avvicinarcisi, con cautela, rispettando ogni libertà.
Giacomo
La scuola in Italia ha punti di forza e punti di debolezza. Tra le cose che mancano mi viene in mente la possibilità di conoscersi, e non solo di conoscere. Andare a scuola vuol dire, inevitabilmente, studiare e ripetere, imparare si, ma spesso senza trovare uno spazio per l’utilizzo pratico di quel sapere. Così il sapere acquisito rimane chiuso all’interno della mente della studentessa o dello studente fino alla prova, al risultato, e poi può essere tranquillamente dimenticato. Mancano quegli spazi di ascolto, quei momenti importantissimi in cui si impara per davvero a dire cosa si pensa, a discutere, a creare una propria opinione e condividerla con altri. Mancano i momenti dedicati al dibattito, alla riflessione, che sono quelli che più contribuiscono alla crescita di un/una giovane. Quei momenti in cui ci si siede in cerchio, senza i banchi e senza fogli, usando solo i propri occhi, le parole che escono dalla bocca, le orecchie aperte, essenziali per sviluppare la capacità di ascolto, e si condivide. Si parla della propria visione del mondo, a cosa serve ciò che si è imparato, chi si vuole diventare: non è davvero importante l’argomento quanto lo è il fatto che tutti parlino, che tutti si ascoltino, che tutti imparino a dire la propria senza vergogna, ma soprattutto, con fiducia nella comprensione e nel rispetto di chi si ha accanto. Questa, per me, potrebbe essere un’idea di scuola che ci aiuta davvero a prepararci al futuro.
Annalisa
Il sistema scolastico viene spesso presentato come il pilastro della formazione delle nuove generazioni, il luogo in cui si sviluppano competenze, pensiero critico e strumenti per affrontare il futuro. Ma la realtà appare più complessa. Le lezioni frontali, cuore della didattica tradizionale, hanno certamente un valore: trasmettono conoscenze, offrono un quadro storico e teorico di riferimento. Tuttavia, se restano confinate a un flusso unidirezionale di nozioni, rischiano di soffocare la capacità degli studenti di interrogare, immaginare, mettere in dubbio. Il pensiero critico si sviluppa davvero quando la lezione diventa dialogo, quando ci si chiede collettivamente “cosa ne pensiamo di questo evento?”, “quali alternative erano possibili?”, “quali limiti ha questa interpretazione?”. Perfino le risposte confuse o “sbagliate” possono essere preziose, perché costringono a rimettere in discussione ciò che il potere, o la tradizione, hanno già stabilito come verità.
Ma non si cresce soltanto attraverso i contenuti. La scuola educa anche tramite la sua stessa struttura sociale: le classi costringono a confrontarsi con lo sconosciuto, a convivere con chi è diverso, a misurarsi con i conflitti. In questo senso, l’istituzione scolastica riproduce dinamiche politiche e sociali: si impara a organizzarsi con i rappresentanti di classe o d’istituto, a contestare decisioni prese dall’alto, a immaginare piccole forme di democrazia quotidiana.
Eppure, questa dimensione potenziale rimane troppo spesso irrealizzata. Nella mia esperienza, ciò che prevale è la disillusione: più burocrazia che partecipazione, più imposizione che dialogo. La scuola non riesce a essere fino in fondo un laboratorio di cittadinanza critica, e non sempre prepara davvero al futuro. Tutto dipende dalla qualità e dalla sensibilità degli insegnanti: alcuni riescono a stimolare la curiosità e la riflessione, ma molti altri, stando ai racconti raccolti e vissuti in prima persona, finiscono per riprodurre modelli gerarchici, rigidi, scarsamente orientati alla crescita personale.
Per questo, rispondere alla domanda se la scuola ci prepari o meno è inevitabile: no, non lo fa in maniera completa. Non garantisce lo sviluppo di un pensiero critico né una reale preparazione al futuro, se non in misura frammentaria e fortemente variabile. È difficile pensare di affidare una responsabilità così grande unicamente a insegnanti lasciati a gestirsi in autonomia, spesso senza strumenti né formazione adeguata. Il rischio è che le generazioni crescano senza quelle competenze che più servono in una società complessa: la capacità di interrogare, di immaginare alternative, di costruire insieme il cambiamento.
Alessia